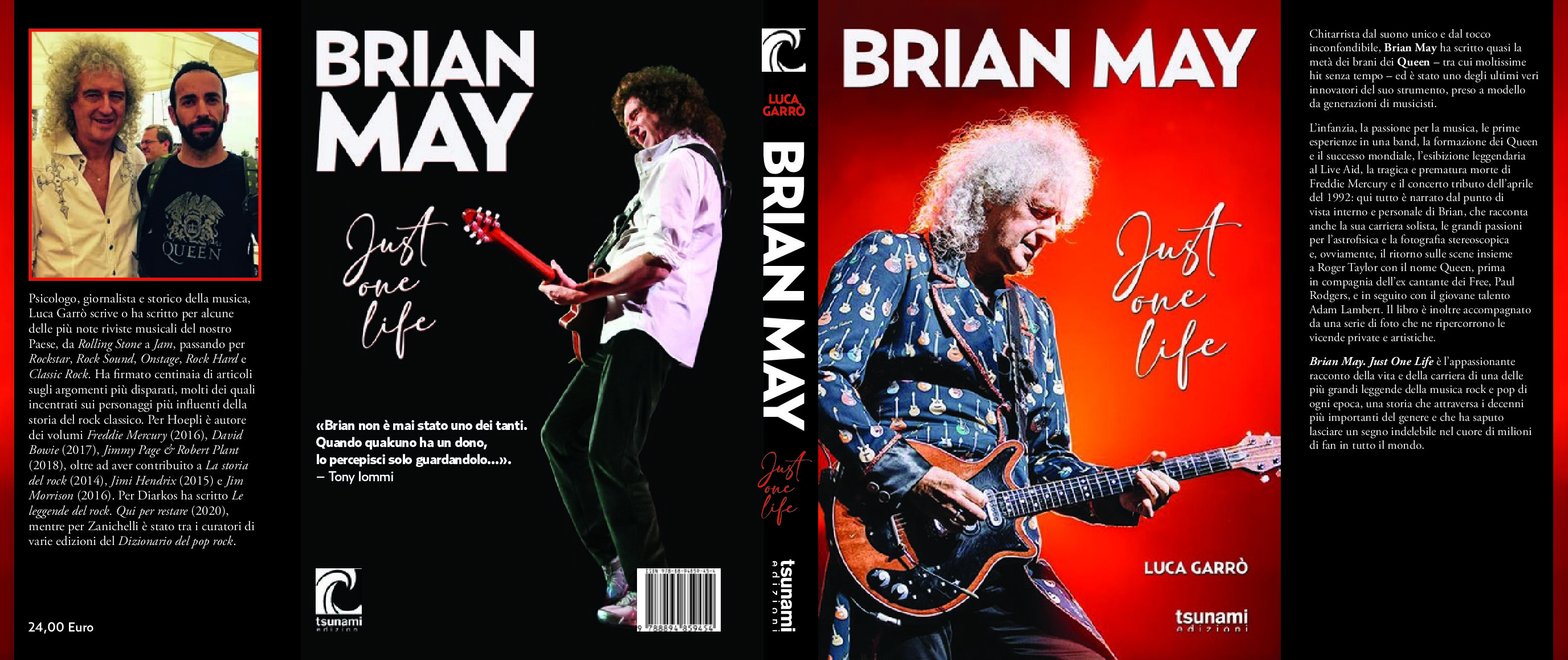C’è poco da fare: nella musica, così come in ogni altro ambito, non tutti gli anni sono uguali. I motivi, in genere, vanno ricercati all’interno della società e del costume, ma talvolta è semplicemente il caso a decidere le sorti di un disco piuttosto che di un altro. Album bellissimi resteranno per sempre amati da una manciata di persone ed opere trascurabili, invece, riempiranno sempre le collezioni degli appassionati in ogni angolo del pianeta. Con la storia del rock che perde quotidianamente pezzi da novanta è facile rivolgere il proprio sguardo al passato, oggi più che mai. Col senno di poi, a distanza di quarant’anni, è facile riconoscere nel 1976 un anno emblematico per il futuro del rock n roll. Mentre la maggior parte delle band progressive portavano agli estremi idee (e assoli) che inizialmente erano sembrate una boccata d’aria sana, nuovi fermenti erano a pronti a sconvolgere il music business mondiale per l’ennesima volta. Se, da un lato, band ormai storiche come i Rolling Stones cercavano di svecchiare il proprio sound con le sonorità funk e raggae di un album di transizione come Black And Blue, altre da una parte all’altra dell’oceano, raggiungevano il proprio picco creativo. Gli Aerosmith, ad esempio, davano alle stampe Rocks, probabilmente il loro disco più rappresentativo del decennio. Dopo il successo di Toys In The Attic, la band di Boston aveva il mondo ai propri piedi, senza aver ancora raggiunto il proprio zenit creativo: la cosa migliore era quindi quella di tornare immediatamente in studio e capitalizzare quanto seminato con le prime tre pubblicazioni. Rocks, per molti uno dei dischi assoluti degli anni settanta, conteneva tutto quello che qualsiasi album rock dovrebbe possedere: brani tirati ma allo stesso tempo accessibili, produzione perfetta e band al top della sintonia. Gente come Slash, Nikki Sixx e James Hatfield hanno dichiarato che senza questo disco non avrebbero iniziato a comporre musica, ma a sconvolgere maggiormente restano ancora le parole di Kurt Cobain, che definì decine di volte Rocks uno dei suoi album preferiti di sempre. E se pensate al fatto che, in piena era grunge, gli Aerosmith scuotevano MTV con ballad come Cryin’ o Crazy, la cosa fa ancora più impressione. Se per tutti Boston era ormai la città di Joe Perry e Steven Tyler, una giovane band stava per scuotere notevolmente il sound americano, tanto da diventare uno dei simboli di quel AOR che avrebbe imperversato per diversi anni nella radio americane: i Boston di Tom Scholz e Brad Delp. Il loro disco di debutto fu il classico fulmine a ciel sereno: al di là del fatto che avere come opener un brano come More Than A Feeling un pochino possa aiutare, erano le armonie e il suono di Scholz a rompere davvero col passato. Fino ad allora non si era mai sentito un uso della chitarra di quel tipo e questo, unito alle capacità vocali di Delp e ad una commistione tra progressive e hard rock azzeccatissima, fece di Boston uno dei debutti più venduti di sempre. Diverso il caso dei Blue Oyster Cult. Quella che ancora oggi resta una delle band meno comprese della storia, in quell’anno non diede alla luce il proprio album più riuscito, ma quello che li avrebbe proiettati nella storia della musica popolare. Agent Of Fortune valeva la metà dei suoi predecessori, ma la presenza della celeberrima Don’t Fear The Reaper lo rese immediatamente il loro lavoro più accessibile di sempre. Non che l’album fosse avaro di perle ma, come accade sempre in questi casi, la presenza di un brano di quella portata (radiofonica, in primis) finì per portare tutto via con sé. È la condanna dei grandi inni: per tutta la vita speri di scriverne uno e quando questo diventa più grande di te, fai di tutto per cercare di liberartene. Ad ogni modo, nonostante qualche altro picco sporadico successivo, la band aveva già sparato tutte le proprie cartucce e Agent Of Fortune viene considerato ancora oggi come l’epilogo del ciclo creativo che aveva dato origine a capolavori come Tyranny And Mutation e Secret Treaties. Nello stesso periodo, un altro gruppo raggiungeva il proprio apice, di vendite e probabilmente artistico: gli Eagles. Hotel California è il classico disco che tutti hanno in casa, anche quelli che non sopportano la band americana. Iniziamo col dire che il quinto album del gruppo fu anche il primo con Joe Walsh, il quale, pur partecipando alla scrittura di un solo brano, si rivelerà fondamentale per il successo dell’album e per il futuro del gruppo. Posizionato al numero trentasette della classifica dei migliori cinquecento album dalla rivista Rolling Stone, Hotel California è un album sostanzialmente perfetto e rappresenta al meglio le sonorità della West Coast americana della metà degli anni settanta. Inoltre, è da sempre ammantato di quell’aura di mistero che aiuta non poco la fortuna di un disco: la copertina, che per anni ha fatto discutere addetti ai lavori e fan, è da sempre oggetto di dispute accese, così come i presunti riferimenti satanici che riempirebbero i solchi dell’album stesso. Tutti rumors che negli anni ne hanno accresciuto notevolmente il fascino morboso. Che l’America a metà degli anni settanta fosse un immenso melting pot di sonorità e generi lo dimostra anche il successo oltre ogni aspettativa di Leftoverture, il quarto album dei Kansas: ideale spartiacque tra East e West Coast, la band capitanata da Steve Walsh riuscì a vendere oltre cinque milioni di copie con un album sì al passo coi tempi, ma non certo così innovativo come potesse sembrare. Ad ogni modo, il nucleo di fan reclutato nel corso degli anni precedenti era andato sempre a crescere, tanto da portare la band ad essere uno dei main act dal vivo del periodo. Meno rassicuranti, ma sempre più paraculi, erano invece i Kiss: reduci dal successo mostruoso di Alive!, Gene Simmons e soci entrarono in studio convinti di dare la luce al loro capolavoro. Talvolta, quella può sembrare presunzione non è altro che piena consapevolezza del proprio potenziale: con brani come Detroit Rock City, God Of Thunder, Shout It Out Loud e Beth i Kiss erano infatti semplicemente riusciti a creare metà delle proprie setlist dei quarant’anni successivi. L’altra metà, in pratica, la completarono nei due anni successivi. Anche la disco music prendeva sempre più piede, tanto che vere e proprie icone del genere come Donna Summer iniziavano ad ottenere i primi veri successi in patria. Allontanatasi dagli States perché impegnata con il musical Hair, la Summer venne notata in Europa da Giorgio Moroder, che la prese sotto la propria ala protettrice. Nel giro di pochi anni, grazie alle idee di Moroder e ad una serie di brani accattivanti e giocati spesso su ammiccamenti sessuali nemmeno troppo velati, la cantante si mise in evidenza come una delle artiste più rappresentative dell’era della disco music. A Love Trilogy, pur ancora acerbo, fu comunque in grado di spalancarle le porte della celebrità: da quel momento in poi, nonostante gli alti e bassi del genere, la sua stella continuerà a brillare. Contemporaneamente, altri due artisti vivevano un momento di grande ispirazione: Stevie Wonder e Tom Waits. Il primo, grazie al successo di dischi come Talking Book, Innervisions e Fulfillingness’ First Finale era ormai all’apice della propria carriera. Seppur solo ventiseienne, quando uscì Songs In The Key Of Life Wonder aveva già pubblicato quasi venti dischi, una cifra che oggi ha davvero dell’incredibile. Il nuovo lavoro, per tutti il suo capolavoro assoluto, racchiudeva un po’ tutto il credo dell’artista americano e ancora oggi resta un punto di riferimento assoluto per chiunque si approcci non solo al soul, ma a quasi tutto quello che il termine musica popolare può significare. Diverso il caso di Tom Waits: Small Change era solo il terzo album da studio della sua carriera, ma di certo era il prodotto di un artista ben consapevole del proprio spazio nel mondo. Sorta di ibrido tra i testi di Bukowski e la musica di Louis Armstrong, Small Change spiazza ancora oggi, tanto per le scelte stilistiche che per l’intensità delle interpretazioni di Waits. Se però la critica si era già mostrata dalla sua parte, questa volta furono le vendite a sorprendere, decretando di fatto il primo vero successo della sua infinita carriera. Lo scossone più clamoroso arrivò però dalla costa est degli Stati Uniti, una scossa che a distanza di qualche mese avrebbe dato il via al fenomeno più rivoluzionario del decennio: il punk. Come tutti sono convinti del fatto che la prima guerra mondiale sia iniziata nel 1915 e non l’anno precedente, così la maggior parte della gente crede che il punk sia un fenomeno nato nel 1977. È noto, invece, che un reietto come Dee Dee Ramone fosse l’idolo dichiarato di Syd Vicious. Un articolo sul proto punk e sui numi tutelari di un genere finirebbe per occupare pagine e pagine, dunque la cosa più semplice da dire è che il punk, o per lo meno un certo tipo di punk, era già una realtà americana quando esplose nel Regno Unito. I Ramones, in questo senso, furono gli alfieri di quella rivoluzione. Con un album della durata di meno di mezz’ora, in un epoca in cui migliaia di band sceglievano assoli di venti minuti, quattro teppistelli che sniffavano colla e saltavano la scuola diedero vita ad un genere. La formula fu molto semplice: prendere la bubble music e velocizzarla, con l’aggiunta di testi crudi, spesso al limite dell’assurdo e della demenza pura. Non c’è un brano del disco che non sia diventato un loro classico, basterebbe questo a renderlo uno dei dieci album più influenti di sempre. Sullo stesso versante si muovevano altre due figure che avrebbero ricoperto ruoli fondamentali da lì a qualche mese. Proprio come i cuginetti Ramones, i Blondie pubblicavano il loro omonimo debutto: pur contenendo alcune delle loro performance più significative, l’album non ebbe fortuna e provocò la rottura del contratto con la loro casa discografica. Il disco venne quindi ripubblicato l’anno successivo dalla Chrysalis Records, la stessa casa dei Ramones, in piena esplosione mondiale del punk. Ottenne invece maggiore successo Radio Ethiopia di Patti Smith, soprattutto per via del clamore suscitato dal precedente Horses che per meriti veri e propri. Nonostante fosse pieno di buone idee, Radio Ethiopia non possedeva la coesione e la visione musicale del suo predecessore, cosa che portò a diverse critiche non proprie positive. Il successivo, ottimo, Easter finì per relegare l’album in un angolo della discografia della Smith, anche se un anniversario così importante potrebbe rappresentare l’occasione per andare a riscoprire una piccola gemma dimenticata. Il ’76 fu anche l’anno del mistero discografico più inspiegabile di sempre: il successo planetario di Peter Frampton con Frampton Comes Alive. Buon chitarrista, salito alla ribalta fin da giovanissimo per la militanza negli Humble Pie di Steve Marriot, ma sostanzialmente un gregario di lusso, Frampton inizia una carriera solista all’inizio del decennio che non gli procura alcuna soddisfazione. Poi, di colpo, il paradiso: per ragioni ancora del tutto inspiegabili, il suo primo album dal vivo diventa uno dei più venduti della storia. Non sarà né il primo, né l’ultimo caso del genere, ma l’immediata scomparsa dalle classifiche dei dischi successivi fa di Frampton un unicuum difficilissimo da capire, tanto che per ritrovare il suo nome in contesti di questo livello bisognerà aspettare quasi dieci anni, quando David Bowie lo scelse come chitarrista della backin band del Glass Spider Tour. Mentre Frampton Comes Alive scalava le classifiche, lo stesso Duca Bianco si trovava in una delle sue molteplici fasi di transizione che ne avrebbero caratterizzato tutta la carriera: Station To Station, algido e marziale, venne definito allo stesso tempo l’album più accessibile e meno penetrabile di Bowie. Le sonorità a metà tra il funk soul del precedente Young Americans sfumarono in un krautrock che apriva chiaramente la strada alla trilogia berlinese. Restando nel Regno Unito, altri due pezzi da novanta erano alle prese con album importanti, ma non apprezzati appieno dalla critica del tempo: i Queen con A Day At The Races e i Led Zeppelin con Presence. Seppur ricco di brani passati poi alla storia, ADATR pagò lo scotto di giungere dopo un disco come A Night At The Opera, un po’ come chi si dovesse trovare su un palco a suonare dopo uno show dei Rolling Stones. I Queen avevano raggiunto un apice difficilmente eguagliabile, anche se chi scrive resta convinto del fatto che “quei due album” vadano considerati come un unico doppio, forse il più grande della storia del rock. Diverso il caso degli Zep, giunti ad un inevitabile momento di stanca, che portò alla registrazione frettolosa di un disco comunque da rivalutare: se è vero che il gruppo avesse abituato i fan ad una collezione continua di hit, va anche detto che il lavoro di Page su Presence è pressochè sbalorditivo, seppur più duro che in passato. Inoltre, migliaia di band ammazzerebbero per creare anche solo un brano come Achille’s Last Stand…Contemporaneamente Thin Lizzy e Rainbow segnavano per sempre la storia della musica dura britannica, i primi grazie a Jailbreak, uno dei loro capolavori assoluti e i secondi con un disco che nessuno si sarebbe mai immaginato dopo l’uscita di Blackmore dai Deep Purple. Dopo un buon debutto, ancora acerbo e lontano dai fasti porpora, Rising arrivò come un fulmine a ciel sereno, dimostrando che Blackmore non solo non avesse sparato tutte le sue cartucce, ma anche che una nuova stella era definitivamente nata, quella di Ronnie James Dio. Un cenno a parte, infine, va agli AC/DC di Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Uscito nel 1976 sia in Australia che in Europa, Dirty Deeds vide la luce in america solo nel 1981, successivamente alla scomparsa di Bon Scott e al successo planetario di Back In Black. Peccato, perché ad oggi questo resta uno dei pilastri della discografia dei fratelli Young. Intriso delle liriche fuori da ogni schema di Bon Scott e dei classici riff degli Young, l’album contiene alcuni dei brani più celebri della band, nonché Ride On, una delle cose più belle mai scritte dalla band in quarant’anni di carriera.
Anche per l’Italia il 1976 non fu un anno come gli altri. Battisti e Mogol riuscivano a compiere l’ennesimo miracolo discografico con Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, un album trainato dalla celeberrima Ancora Tu, ma che conteneva anche La Compagnia, piccola gemma che Vasco parecchi anni dopo riprenderà con grande successo. Allo stesso tempo, un giovane Francesco De Gregori pubblicava Buffalo Bill, uno degli apici assoluti della sua discografia non solo grazie a brani come la splendida title track, ma anche come la conclusica Santa Lucia, il brano che Lucio Dalla dichiarò sempre essere uno dei suoi preferiti di sempre. Rino Gaetano, che per diventare celebre dovrà aspettare Sanremo e Gianna e per diventare immortale il nuovo millennio, con Mio fratello è figlio unico produceva uno dei dischi più amari e riusciti della musica italiana tutta. Quella malinconia, unita a melodie intense e che puntavano sul lato emotivo e ad un cantato che si potrebbe definite proto grunge, resero il secondo album di Rino probabilmente il più completo. Discorso simile per gli Area, uno di quei gruppi di cui tutti parlano ma pochissimi sanno davvero perché: oggi fa figo dire di amare Stratos e compagni, ma è davvero difficile immaginare la portata di un album come Maudits ai tempi della sua pubblicazione. Ancora lontani dall’essere compresi appieno. Quell’anno vide anche la pubblcazione di Via Paolo Fabbri 43, titolo preso dall’indirizzo della casa bolognese di Francesco Guccini dei tempi. Posizionato al numero ventinove della classifica di Rolling Stone dei migliori album italiani di sempre, il settimo album di Guccini non può lasciare indifferenti nemmeno I detrattori. Basterebbe L’Avvelenata a renderlo imprescindibile, ma è tutto il disco a sorprendere, anche grazie alla velata invettiva contro I colleghi De Andrè, De Gregori e Venditti, contenuta proprio nella title track. Last but not least, il 1976 resterà negli annali anche per Angelo Branduardi, il cui Alla fiera dell’est, oltre a renderlo immortale e conosciuto da grandi e piccini, gli fece vincere anche il Premio Della Critica Discografica Italiana.