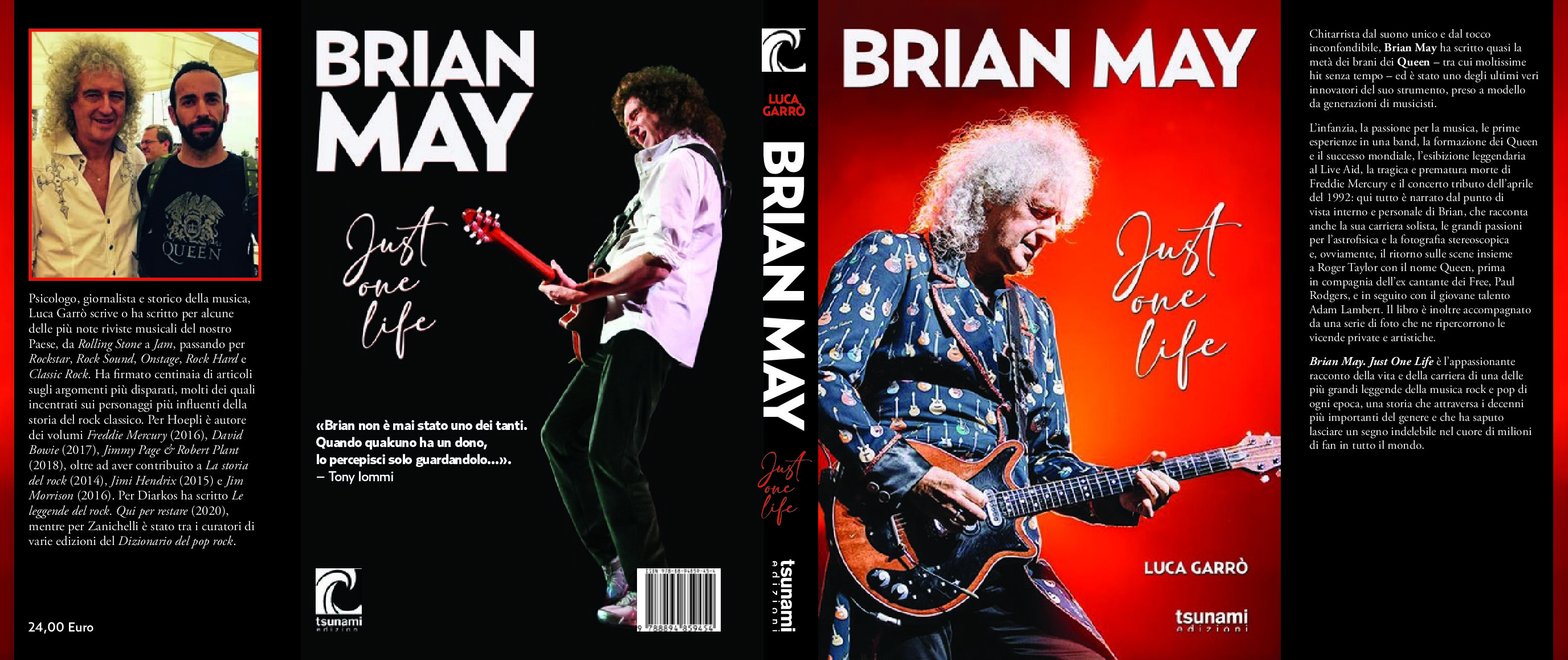Diarkos pubblica il nuovo libro di Luca Garrò, Le Leggende del Rock. Qui per restare. Un viaggio attraverso quarantacinque storie di grandi protagonisti della musica.
Corriere della Musica propone un capitolo tratto dal libro, quello relativo ai Pearl Jam.
PEARL JAM
Immortality
Il 6 dicembre 1994 i negozi di dischi di tutto il mondo vengono inondati da migliaia di copie di Vitalogy, il terzo album d’inediti dei Pearl Jam.
Il titolo, che in origine avrebbe dovuto essere Life, venne cambiato all’ultimo minuto grazie a un libro trovato per caso da Eddie Vedder mentre girovagava tra i banchi di un mercato dell’usato di Seattle. Quel giorno, tra le tante cianfrusaglie, il cantante fu colpito da un trattato pseudoscientifico scritto da E. H. Ruddick, un sedicente medico che aveva raggruppato in quel volume tutta una serie di rimedi popolari, consigli di carattere medico, superstizioni e suggerimenti su come prolungare all’infinito la propria vita. Un testo grottesco e involontariamente esilarante che si sposava alla perfezione con il tema che faceva da sfondo al nuovo disco della band: quello dell’angoscia esistenziale, della paranoia, del rifiuto. Della morte. Un album meno accessibile dei precedenti, in cui anche i testi di si erano fatti meno espliciti e più oscuri.
Se fino ad allora Eddie aveva raccontato per lo più esperienze personali, ora si limitava a dare input, a suggerire, lasciando che fossero gli altri a decidere che strada prendere. I perché di un cambio stilistico del genere non erano il frutto di una semplice scelta fatta a tavolino, ma il risultato di una crisi interiore che aveva toccato la band nella sua interezza. Ten (1991) e Vs. (1993) avevano trasformato i Pearl Jam in una macchina da soldi capace di vendere decine di milioni di dischi, e la cosa non poteva non avere ripercussioni pesantissime per l’equilibrio interno del gruppo. Vedder, in particolare, era sempre più frustrato dall’appropriazione del grunge da parte del mercato, cosa che lo poneva in aperto contrasto col batterista Dave Abbruzzese, che invece aveva iniziato a godersi il successo ottenuto. Come se non bastasse, alcuni membri della band avevano iniziato ad abusare di droga e alcol: «Ero ubriaco e mi rendevo ridicolo», confessò a Cameron Crowe di «Rolling Stone» il chitarrista Mike McCready. «Non sapevo come relazionarmi con Eddie e dopo che il gruppo è decollato mi sono rifugiato nel mio mondo».
Fu nel mezzo di quella situazione fuori controllo che Vedder cominciò a prendere totalmente il comando del processo creativo: non solo iniziò a suonare la chitarra, ma si prese carico quasi interamente della direzione musicale del gruppo, componendo i brani in solitudine. «Non era un atto ostile. In tutta onestà, stavo diventando il membro più riconoscibile del gruppo e sentivo il bisogno di essere maggiormente rappresentato musicalmente. Dovevo farlo anche se significava scrivere da solo le canzoni». Canzoni il cui argomento principale riguardava proprio il rigetto di un sistema nel quale Vedder non si riconosceva.
La mattina dell’8 aprile 1994, mentre la band si divide tra il tour di promozione a Vs. e le registrazioni di Vitalogy, la radio KXRX di Seattle interrompe le trasmissioni per comunicare che il cadavere di Kurt Cobain è stato appena trovato all’interno della sua abitazione. Quella sera, i Pearl Jam sono attesi al Patriot Center di Fairfax, in Virginia. Annullare il concerto sarebbe stato rischioso, meglio elaborare il lutto collettivo suonando. Durante l’esecuzione di Daughter, Vedder inserì un frammento di Hey Hey, My My, il brano di Neil Young che Cobain aveva citato nella sua lettera d’addio e la frase di American Pie in cui si faceva riferimento al giorno in cui la musica era morta. Alla fine di un discorso molto toccante, il cantante esclamò: «Non credo sia una buona cosa elevare se stessi, penso sia pericoloso. A volte, che ti piaccia o meno, la gente ti eleva… Ed è molto facile cadere. Così non voglio essere il messaggero, qualcuno che porta cattive notizie. Uccidi il messaggero, ma nessuno di noi sarebbe qui se non fosse stato per Kurt Cobain».
Pochi giorni dopo, la band annunciò che il concerto al Paramount Theatre di New York del 17 aprile successivo sarebbe stato l’ultimo per molto tempo. Forse l’ultimo in assoluto. Nel backstage del teatro, di fronte ad Allan Jones del «Melody Maker», un provatissimo Eddie Vedder si lasciò andare sul suo stato psicofisico in una delle interviste più sincere della propria vita.
Sai, ho sempre pensato che me ne sarei andato io per primo. Non so perché lo pensavo, semplicemente credevo che sarebbe andata così. Voglio dire, non lo conoscevo bene, ma in un certo senso non è giusto che io sia qui senza di lui. È così difficile credere che se ne sia andato davvero. Ne parlo come se lui fosse ancora qui, vedi. Non riesco a crederci. Non ha alcun senso.
I rapporti tra Nirvana e Pearl Jam erano stati spesso burrascosi, soprattutto a causa delle dichiarazioni di Cobain. L’autore di Smell Like Teen Spirit aveva più volte messo in guardia il pubblico dalle band che seguivano un filone senza crederci, limitandosi a cavalcare un’onda per ottenere la fama. L’oggetto delle sue accuse erano proprio Stone Gossard e Jeff Ament, colpevoli, secondo lui, di aver tradito gli ideali del rock alternativo degli esordi, per seguire una facile via verso il successo. «So per certo che, se non Stoney, almeno Jeff è assolutamente un carrierista, una persona che bacerebbe il culo per assicurarsi che il suo gruppo diventi famoso e lui ricco», aveva dichiarato al biografo Michael Azerrad.
Insomma, per Cobain i Pearl Jam erano i maggiori responsabili della fusione tra rock alternativo e interessi del sistema, ignorando invece che le sue angosce fossero proprio le stesse che Vedder stava dichiarando nei suoi nuovi testi. I due ebbero modo di chiarirsi durante la cerimonia degli Mtv Video Music Awards del 1992. Vedder si trovava nel backstage dello show, quando Courtney Love si avvicinò a lui, coinvolgendolo in un ballo, mentre Eric Clapton suonava Tears In Heaven. Kurt li raggiunse poco dopo:
Lo guardai negli occhi e gli dissi in faccia che comunque ero convinto che il suo gruppo facesse schifo. Però gli dissi: dopo avervi visto suonare, ho capito che tu sei una persona che ha passione. Il mondo è pieno di gente molto peggiore di lui. Ho capito che si trovava nella mia stessa situazione, non meritava di fare il capo espiatorio.
La verità è che pur non potendolo ammettere pubblicamente, i due sapevano di avere molte cose in comune. Come confessò ancora Eddie.
Non ne abbiamo mai parlato, ma so che tu pensi che, anche se eravamo persone molto differenti, probabilmente avevamo molto in comune. Avevamo delle storie simili, sì, cose che erano successe alle nostre famiglie e stronzate del genere. Penso che sia qualcosa che viene fuori quando scriviamo le nostre canzoni, sicuramente. Ci sono delle similitudini ogni tanto. Ma quello che ci rendeva più simili era il modo in cui la gente reagiva a quello che scrivevamo e cantavamo, quell’intensa identificazione. Penso che forse sia stato uno shock per entrambi sapere che così tante persone avevano vissuto le stesse esperienze. Voglio dire, capivano in modo così completo quello di cui parlavamo. E noi pensavamo di essere gli unici ad aver dovuto fare i conti con quella merda. Perché noi in realtà abbiamo scritto quelle canzoni per noi stessi. Poi all’improvviso, c’è tutta questa gente che si riconosce in quelle canzoni e di colpo diventi il portavoce di una cazzo di generazione. Riesci a crederci?
Se fino a quel momento i testi di Vitalogy avevano trattato per lo più il senso di alienazione di una band e del suo leader, dopo la scomparsa di Cobain tutta l’opera finì per assumere le sembianze di un vero e proprio strumento di catarsi globale. Qualcosa con cui tutti i suoi organi avrebbero potuto in qualche modo lenire il proprio dolore.
Le persone come me e come lui… non possiamo essere noi stessi. È una contraddizione. Non possiamo essere semplicemente individui che scrivono quelle canzoni. Dobbiamo rendere conto alle speranze e alle aspettative di milioni di ragazzi, ma non possiamo farlo. E al di sopra di tutto questo ci sono i cinici media del cazzo. Fanculo, che si fottano. Su tutta la linea, mettono in dubbio la tua onestà. Indipendentemente da quello che dici, da quello che fai, pensano che tu agisca con un secondo fine. Pensano che sia tutto un cazzo di gioco. Perché è quello a cui sono abituati. È quello che pensano, che sia un cazzo di gioco. Non sanno distinguere quello che è vero da quello che non lo è. E quando arriva qualcuno che cerca di essere vero, loro non sanno cogliere la cazzo di differenza. Così se dici: no, non giocherò al vostro cazzo di gioco. Voglio andarmene… non farò questo, non farò quello, loro continuano a pensare che tu faccia parte del gioco. Non possono proprio accettare che tu non ne voglia far parte, che tu non ne sei mai stato parte. Pensano sempre che sia una posa. Qualche tipo di posa del cazzo. E questo rende le cose così difficili per qualcuno che cerca solo di essere onesto. E allora che si fottano.
Quella chiacchierata, simile a una seduta di psicoterapia, era riuscita in qualche modo a sbloccare non solo Eddie, ma l’intera band. Nonostante il clima tanto teso, i Pearl Jam mostrarono quella determinazione che sarebbe diventata il loro marchio di fabbrica, e l’album che minacciava di far deragliare la loro carriera finì invece per dare loro un nuovo obiettivo cui mirare. A farne le spese, a registrazioni ormai ultimate, fu Abruzzese. Dopo voci che indicavano in Dave Grohl dei Nirvana il suo sostituto, la scelta cadde su Jeremy Irons, proprio colui che anni prima aveva presentato Vedder al gruppo.
Seppur smentiti costantemente, i rimandi alla tragedia di Cobain sembravano molteplici. In particolare tra le righe di Immortality, un pezzo lento con un ritornello che andava e veniva come un’onda. Anche se alcuni passaggi del brano sembravano riferirsi al suicidio del collega, Vedder preferì non pronunciarsi esplicitamente, forse per non essere strumentalizzato: «Non è su Kurt, ma nel testo ci sono cose che si possono leggere in quel senso e magari possono contribuire a rispondere a qualche domanda o a comprendere le pressioni a cui è sottoposto una persona che viaggia su binari paralleli al tuo».
Con Vitalogy, i Pearl Jam si liberarono del peso di un’eredità che non volevano fare propria. Una presa di posizione perseguita nel tempo, continuando a portare avanti la loro idea di un rock fatto di etica e coerenza. Permettendosi anche di sbagliare, ma senza mai diventare i portavoce di nessuno.
As privileged as a whore / Victims in demand for public show / Swept out through the cracks beneath the door / Holier than thou, how / Surrendered, executed, anyhow /Scrawl dissolved, cigar box on the floor / A truant finds home / And a wish to hold on too / He saw the trapdoor in the sun / Immortality…
Discografia essenziale:
– Ten (1991)
– Vs. (1993)
– Vitalogy (1994)
– Live On Two Legs (1998)